Locri (RC). Per la Giornata nazionale del Paesaggio al museo Archeologico nazionale giornata di studi “Archeologia e Paesaggio tra contemporaneità e storia”. Ecco il programma

Il 14 marzo 2025, alle 17.30, al museo Archeologico nazionale di Locri Epizefiri, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio 2025, giornata di studi “Archeologia e Paesaggio tra contemporaneità e storia”. Introduce Elena Trunfio, direttrice del museo e parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri. Saluti istituzionali: Fabrizio Sudano, direttore della direzione regionale Musei nazionali Calabria; Maria Mallemace, soprintendente ABAP per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; Giuseppe Fontana, sindaco di Locri. Interviene: Paolo Mighetto, soprintendenza ABAP RC VV, su “Temi di gestione e cura della componente naturale del Patrimonio Culturale nei parchi archeologici” in dialogo con Elena Trunfio, direttrice del museo e parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri; Ilario Tassone, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di RC; Antonino Sgrò, presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di RC. Modera Michelangelo Pugliese, architetto e paesaggista, università Federico II di Napoli.
Castellammare di Stabia (Na). Incontro pubblico alla Reggia di Quisisana per illustrare i progetti di restauro della Torre Colombaia e l’area verde competente. “Nessun albero abbattuto, né sono previsti abbattimenti”

La Torre Colombaia nel parco della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia è interessata da lavori di restauro e valorizzazione (foto parco archeologico pompei)
“Nessun albero è stato abbattuto né sono previsti abbattimenti nell’ambito dei progetti di restauro e valorizzazione della Torre Colombaia, complesso che unisce valori unici di carattere sia naturalistico sia culturale”, assicura la direzione del parco archeologico di Pompei. E mercoledì 31 maggio 2023, alle 11, alla Reggia di Quisisana, a Castellammare di Stabia (Na), incontro con la responsabile del sito, Maria Rispoli, e il direttore dei lavori della gestione del verde del Parco archeologico di Pompei, Paolo Mighetto, per rendere noti a tutta la cittadinanza e alle associazioni interessate i progetti che riguarderanno l’intera struttura. È in corso di valutazione e analisi, infatti, lo stato di salute di tutti gli alberi del parco, per l’area di afferenza del Parco archeologico di Pompei, con l’ausilio di agronomi e giardinieri d’arte restauratori del verde, al fine di definirne una accurata anamnesi dello stato di conservazione, nell’istanza prioritaria della loro cura, tutela e valorizzazione. “Nel contempo”, informa il Parco archeologico di Pompei, “i lavori di restauro e consolidamento della Torre Colombaia, monumento risalente al XIV secolo di grande pregio, oggetto di un progetto di restauro conservativo, sono attualmente sospesi per consentire la progettazione di ulteriori interventi, resisi necessari a causa del degrado avanzato in cui versava la torre”. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di interventi per il restauro e la fruizione di una parte del complesso borbonico della Reggia di Quisisana, in base a un accordo di valorizzazione con il Comune di Castellammare di Stabia.
Pompei. Un anello verde di quattro chilometri per rigenerare il paesaggio extramoenia del Parco. La presentazione del Masterplan in auditorium

Il progetto di riqualificazione del paesaggio di Pompei: un anello verde esterno le mura antiche (foto parco archeologico pompei)
L’obiettivo è la riqualificazione di un percorso paesaggistico di circa 4 chilometri extramoenia del Parco archeologico di Pompei, per farne un vero e proprio anello verde attorno alla città antica, capace di valorizzare il legame tra l’area degli scavi e il paesaggio naturale e agricolo circostante. Il Masterplan – oggetto di finanziamenti con fondi del PNRR – sarà presentato martedì 30 maggio 2023, alle 10.30, all’Auditorium degli scavi di Pompei. Alla presentazione interverranno: Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del parco archeologico di Pompei; Angelantonio Orlando, direttore generale Unità di missione per l’attuazione del PNRR; Vincenzo Calvanese, responsabile Ufficio tecnico del parco archeologico di Pompei; Paolo Mighetto, funzionario del parco archeologico di Pompei e RUP; Giovanni Minucci, cooperativa sociale Il Tulipano; Alberto Giuntoli, paesaggista e partner Studio Bellesi Giuntoli. Elementi portanti del nuovo percorso in extramoenia sono: il ripristino della passeggiata lungo le mura, la valorizzazione dei belvedere e la formazione di nuovi punti paesaggistici, il percorso ciclabile e quello viabilistico per servizio, le aree di sosta e di svago, quelle per il jogging e per il fitness, uniti ai punti di osservazione ornitologica e agli apiari. Il fine degli interventi sarà quello di restituire alla fruizione dei visitatori un’area strategica per la conoscenza dell’antica Pompei, di valenza paesaggistica unica al mondo e che oggi ancora, risulta in parte sottratta al godimento pubblico e non del tutto integrata al percorso di visita.

Panoramica dell’Insula Occidentalis a Pompei (foto parco archeologico pompei)
Chi viene oggi a Pompei per la prima volta, non conosce l’esistenza di un’altra Pompei esterna alle mura perché, anche a causa dei cantieri di restauro di questi ultimi anni, quello che alla fine degli anni Novanta era stato pensato come un vero e proprio circuito pedonale e ciclabile di circa 4 chilometri all’esterno delle mura della città antica, di grande valenza paesaggistica, è andato progressivamente degradandosi e perdendosi. È solo in questi anni recentissimi che, riattivando una corretta e continuativa manutenzione del verde, è stato possibile riscoprire e recuperare molte delle aree esterne, in alcuni casi avviando una vera e propria bonifica dalla vegetazione infestante che si era impadronita dei luoghi. Inoltre, la bonifica del grande frutteto dell’Insula Occidentalis e della Via dei Sepolcri al di sopra della Villa di Cicerone, con il nuovo viale dei cipressi tra l’Anfiteatro e Porta Nola, rappresentano due tasselli di un recupero che oggi, con il completamento della nuova recinzione del parco, hanno consentito di avviare un ripensamento e una riqualificazione dell’intero circuito estrameniano.

Agricoltura sociale: raccolta di mele e melograni a Pompei con la coop sociale Il Tulipano (foto parco archeologico pompei)
La progettazione, seguita dal Parco e dallo Studio Bellesi Giuntoli di Firenze, includerà anche la redazione del PEBA, cioè del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, fisiche e senso-percettive, esteso all’intero perimetro estrameniano e a questa seguirà la progettazione degli interventi specifici e mirati ad assicurare l’accessibilità ampliata dell’area interessata. “L’intento è anche quello di pervenire a livelli di fruizione del circuito estrameniano in piena sicurezza e secondo forme di autonomia differenziata, ricreando percorsi che consentano l’inclusione e dunque la percorribilità da parte di tutti, evitando percorsi riservati esclusivamente ai disabili, nell’ottica di un’accoglienza inclusiva e senza barriere”, sottolinea il direttore Zuchtriegel. “Per questo è stato anche avviato un percorso di stretto e proficuo dialogo progettuale con la Cooperativa Sociale Il Tulipano, già attiva al Parco di Pompei, al fine di predisporre aree e percorsi pienamente inclusivi anche per Persone con autismo e/o disabilità cognitiva”.
Pompei verso una nuova gestione del patrimonio verde: bando per individuare un partner privato di eccellenza per collaborare nella gestione dei vigneti archeologici, nonché nell’intero ciclo (dall’impianto alla commercializzazione). Il direttore Zuchtriegel presenta il progetto

Il vigneto della Casa della Nave Europa a Pompei (foto parco archeologico pompei)
Si chiamerà dell’Azienda Agricola Pompei e avrà il compito di gestire il patrimonio verde del parco archeologico di Pompei. Una sfida importante che sarà realizzata attraverso un processo partenariale pubblico–privato, di cui il primo passo è l’avviso internazionale che il parco archeologico di Pompei ha pubblicato per la co-gestione dei terreni destinati e da destinare a vigneto e al ciclo produttivo del vino, in scadenza il prossimo 26 agosto. Ai vigneti già presenti nelle Regiones I e II di Pompei e nel sito di Villa Regina a Boscoreale, estesi per quasi due ettari, si aggiungeranno altri cinque ettari di nuovi impianti di assoluta eccellenza e gestiti secondo i dettami esclusivi della lotta biologica “artigianale/naturale” e nel rispetto ed interpretazione aggiornata delle tecniche e modalità colturali del mondo antico. L’ambizioso programma di attuazione delle attività a partire dall’Avviso internazionale appena pubblicato sarà illustrato martedì 19 luglio 2022, alle 12, al vigneto della Casa della nave Europa, l’antica dimora di un importante produttore e commerciante di vino, olio e altri prodotti agricoli. Interverranno Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del parco archeologico di Pompei; Pierpaolo Forte, consigliere di amministrazione del Parco e professore ordinario di diritto amministrativo all’università del Sannio; e Paolo Mighetto, responsabile della manutenzione del verde del parco archeologico di Pompei.

I vigneti dei praedia di Giulia Felice a Pompei (foto parco archeologico di Pompei)
I vigneti saranno impiantati nelle aree archeologiche di Pompei, Stabia, Boscoreale e presso il Polverificio Borbonico di Scafati, sia nella forma di allevamento a palo e alberello, sia a spalliera su terrazzamenti, con una particolare attenzione all’impostazione paesaggistica, coltivati e gestiti dall’impianto alla produzione, dall’imbottigliamento all’affinamento e fino alla vendita all’interno dello stesso Parco archeologico. L’obiettivo è quello di una gestione del Patrimonio naturale che può diventare motore di sviluppo per una nuova fruizione ampliata del Parco, per renderlo energeticamente autosufficiente, per potenziarlo come presidio della biodiversità all’avanzare dell’inurbamento, per renderlo propulsore di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e da quello sociale e legale.
Pompei. Con l’architetto Mighetto alla scoperta dei lavori di messa in sicurezza e restauro della Casa della Biblioteca nell’Insula Occidentalis: una sfida per offrire ai visitatori i segni delle distruzioni subite dalla città antica

La Casa della Biblioteca è una delle eleganti domus, assieme a quelle di Marco Fabio Rufo e di Maio Castricio, e alla Casa del Bracciale d’Oro che fanno parte dell’Insula Occidentalis di Pompei, dove è in corso il cantiere di messa in sicurezza, al termine del quale gli edifici saranno restituiti alla fruizione del pubblico. Ce ne parla l’architetto Paolo Mighetto che racconta gli interventi in corso e i nuovi dati scientifici che stanno emergendo dalle attività di scavo.
“Ci accoglie nella Casa della Biblioteca”, esordisce Mighetto, “il poeta del V sec. a.C. Filosseno di Citera: lo sappiamo – già da qualche tempo – per la scritta e il nome inciso all’interno di questo affresco. È una casa molto particolare di Pompei, nell’Insula Occidentalis, grande complesso di edifici che si affacciava sul Golfo di Napoli, che si imposta sulle antiche mura della città, e si estende da Porta Marina a Porta Ercolano. All’interno di quest’insula, in particolare quattro domus sono oggetto di un cantiere di restauro, di messa in sicurezza e di scavo archeologico: sono le domus di Maio Castricio, Marco Fabio Rufo, del Bracciale d’Oro, e appunto questa della Biblioteca. Perché Casa della Biblioteca? Proprio perché qui fu recuperato un armadio, meglio le tracce di un armadio, con i rotoli del proprietario di questa domus che doveva essere una persona molto colta, probabilmente appartenente anche a un circolo culturale se volle farsi affrescare sulle pareti della propria biblioteca, appunto una figura un po’ particolare, non proprio a tutti nota, come quella di questo poeta ditirambico Filosseno di Citera”.

“Nel quadro della messa in sicurezza – continua l’architetto -, il restauro di quest’insula ha ripristinato-recuperato gli scavi già in parte eseguiti negli anni ’70, ed è proseguito. In questo prosieguo lo scavo archeologico sta facendo emergere una serie di novità eccezionali. Prima di tutto i segni che si susseguono nel tempo a Pompei, che sono i segni di immani distruzioni. Non solo l’eruzione del 79 d.C. ma il grande terremoto del 62 d.C. che sconvolge la città e questa parte di città in particolare. A seguito di questo grande terremoto la casa, che viene abitata e continua a essere abitata, viene ristrutturata: e noi abbiamo i segni di questa ristrutturazione. Prima dell’eruzione del 79 d.C. infatti sicuramente Pompei subisce una serie di sciami sismici, di eventi sismici che dovettero portare gli stessi proprietari di casa a ristrutturare più volte e in questo nostro lavoro di studio stiamo recuperando proprio i segni anche di questi lavori che dovevano essere in corso al momento dell’eruzione. Al momento dell’eruzione Pompei viene letteralmente coperta dallo strato di materiale vulcanico, da cenere, lapilli, fino ad arrivare ai flussi cineritici che sconvolgono gli ambienti in cui ci troviamo e sigillano tutto fino alla metà del Settecento quando Pompei viene riscoperta, e i Borboni avviano gli scavi, che si sviluppano in sotterranea, quindi attraverso l’apertura di tunnel che si incuneano al di sotto e dentro questo materiale vulcanico, e vanno alla scoperta dei tesori che oggi sono conservati al museo Archeologico nazionale di Napoli”.

“Anche in queste Case vediamo queste tracce che stiamo cercando di conservare proprio come un dato di un ulteriore “sconvolgimento” di ciò che fu Pompei e che è ancora oggi Pompei. E altri segni ancora in epoca successiva. Forse non tutti sanno che Pompei nel settembre 1943 fu bombardata. E fu bombardata a ripetizione, più volte. Oltre 100 ordigni caddero sulla città antica, e due di questi ordigni caddero proprio in questa casa, e si incunearono negli ambienti limitrofi, uno nel tablino, andando a sconvolgere ancora i resti di queste architetture. Ecco, la nostra sfida è proprio quella di portare i futuri visitatori a riscoprire queste tracce del passato e quindi a poter leggere tutti questi eventi disastrosi, i segni di questi eventi: le deformazioni murarie, le lesioni lasciate da tutte queste successioni di eventi devastanti. È una sfida ed è una sfida di questo cantiere”.
Giornata nazionale del Paesaggio. Il Parco archeologico di Pompei propone on line una passeggiata alla scoperta dai paesaggi modellati dal Vesuvio, al verde recuperato nelle domus o fuori le mura, ai giardini ricreati negli affreschi, al paesaggio protostorico di Longola

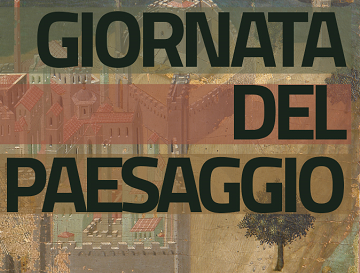 Il paesaggio pompeiano, dalle rappresentazioni nella pittura parietale, al racconto dell’eruzione e delle conseguenti trasformazioni, fino alla complessa manutenzione degli attuali spazi verdi, protagonista domenica 14 marzo 2021 della Giornata nazionale del Paesaggio istituita dal ministero della Cultura allo scopo di promuovere le risorse paesaggistiche attraverso attività di sensibilizzazione, educazione e conoscenza del paesaggio, quest’anno necessariamente on-line. Per l’occasione il Parco Archeologico di Pompei propone, attraverso alcuni video sui canali social e web istituzionali, un racconto del paesaggio pompeiano, dalle trasformazioni subite a seguito dell’eruzione, alle complesse esigenze di manutenzione delle attuali grandi aree verdi incluse nell’area archeologica, fino ai progetti di riqualificazione, ricostruzione e valorizzazione dei giardini storici, che costituivano un elemento centrale della domus romana. Accompagnati da un foto racconto delle più belle scene di paesaggio che caratterizzano le pitture di molte case.
Il paesaggio pompeiano, dalle rappresentazioni nella pittura parietale, al racconto dell’eruzione e delle conseguenti trasformazioni, fino alla complessa manutenzione degli attuali spazi verdi, protagonista domenica 14 marzo 2021 della Giornata nazionale del Paesaggio istituita dal ministero della Cultura allo scopo di promuovere le risorse paesaggistiche attraverso attività di sensibilizzazione, educazione e conoscenza del paesaggio, quest’anno necessariamente on-line. Per l’occasione il Parco Archeologico di Pompei propone, attraverso alcuni video sui canali social e web istituzionali, un racconto del paesaggio pompeiano, dalle trasformazioni subite a seguito dell’eruzione, alle complesse esigenze di manutenzione delle attuali grandi aree verdi incluse nell’area archeologica, fino ai progetti di riqualificazione, ricostruzione e valorizzazione dei giardini storici, che costituivano un elemento centrale della domus romana. Accompagnati da un foto racconto delle più belle scene di paesaggio che caratterizzano le pitture di molte case.

Dall’insula dei Casti Amanti, dove è attualmente in corso un cantiere di messa in sicurezza dei fronti di scavo e rifacimento delle coperture, il vulcanologo Domenico Sparice e il geologo Vincenzo Amato del Parco illustrano la stratigrafia dell’eruzione del 79 d. C. emersa con particolare evidenza nel corso del cantiere, in una sezione a ridosso di uno degli ambienti su cui si sta intervenendo, allo scopo di raccontare le fasi e le dinamiche del tragico evento che seppellì Pompei e le conseguenti mutazioni paesaggistiche e geologiche. Inoltre per la prima volta vengono mostrati e narrati gli strati che costituiscono il sottosuolo della città: strati che raccontano una lunga storia di frequentazioni preistoriche, eruzioni vulcaniche, risorse naturali e cambiamenti del paesaggio.
“Ci troviamo oggi in uno dei vicoli dell’insula dei Casti Amanti nella Regio IX del sito archeologico di Pompei dove si può vedere la sequenza stratigrafica tipica dei depositi dell’eruzione del 79 d.C. nel parco archeologico di Pompei”, spiega Domenico Sparice. “L’eruzione del 79 d.C. è stata una delle maggiori e più violente nella storia del Vesuvio. Nel giro di circa 30 ore furono eruttati circa 4 Km cubici di materiali vulcanici, esattamente ceneri e lapilli. La stratigrafia tipica dell’eruzione è formata essenzialmente da due unità principali. Una è formata dalle famose pomici di Pompei, lapilli che sono caduti dalla colonna eruttiva che hanno una peculiarità, e cioè hanno una variazione verticale di colore, dal bianco alla base al grigio nella parte alta, e questa variazione di colore è dovuta a una variazione della composizione chimica del magma durante l’eruzione. Questi lapilli sono il frutto della prima fase dell’eruzione, ovvero quando sul cratere del vulcano si è formata una colonna eruttiva alta, molto probabilmente, fino a 30 km dalla quale sono caduti i lapilli in atmosfera, sedimentando principalmente nel settore sud-orientale del vulcano, e quindi seppellendo Pompei sotto una coltre di quasi tre metri di pomice. La parte alta della sequenza è invece formata da ceneri, ceneri stratificate con meccanismo deposizionale da correnti piroclastiche. Le correnti piroclastiche sono misture di gas, cenere e lapilli a alta temperatura che scorrono sui fianchi del vulcano per effetto della gravità sostenuta dal gas. La parte alta della sequenza è la parte di cenere stratificata che rappresenta i depositi sedimentati da più correnti piroclastiche che hanno invaso l’area di Pompei durante la seconda fase dell’eruzione. Una di queste correnti piroclastiche, la seconda in particolare arrivata a Pompei, è stata particolarmente violenta, particolarmente energetica. Era diluita, turbolenta, molto molto forte – continua il vulcanologo -, talmente energetica che è stata capace di abbattere pareti trasversali alla direzione di scorrimento della corrente. Questa corrente è stata talmente violenta che ha sepolto quasi completamente gli edifici di Pompei. Ha generato molte vittime, e di alcune di queste vittime è stato possibile fare calchi, proprio perché i corpi si sono decomposti all’interno della cenere ed è rimasto quindi il vuoto in negativo che ha conservato la forma del corpo. Dopo questa corrente piroclastica molto molto violenta, Pompei era semplicemente una landa desolata: la corrente piroclastica aveva seminato morte e distruzione. E le successive correnti piroclastiche che si sono susseguite nel secondo giorno dell’eruzione hanno semplicemente contribuito a smantellare la città di Pompei già quasi completamente sepolta con un’ulteriore coltre di cenere che ha definitivamente sepolto Pompei sotto almeno sette metri di cenere e lapilli”.
“Siamo nel vicolo Ovest dell’insula dei Casti Amanti dove, caso raro a Pompei, si è deciso di indagare il sottosuolo che sta più in basso delle strutture abitative note a Pompei, sepolte dall’eruzione distruttiva del 79 d.C. In questo cantiere si sono aperti ben 12 saggi, 6 nel vicolo Ovest e 6 nel vicolo Est, che hanno permesso di indagare tutta la storia stratigrafica del sito di Pompei fino al raggiungimento del banco lavico che costituiva in antico l’edificio vulcanico di Pompei: la prima forma di paesaggio distinguibile ancora oggi nonostante il ricoprimento avuto ad opera dei prodotti delle eruzioni più recenti che hanno determinato la scomparsa di Pompei. Alcune forme del paesaggio sono ancora ricostruibili, e soprattutto la forma del cratere più grande di Pompei che ha dato vita a queste manifestazioni laviche che in questi saggi di scavo sono stati raggiunti e per la prima volta indagati in dettaglio. Ma non solo questo. Il sottosuolo di Pompei ci racconta una lunga storia di eventi vulcanici, anche se di entità minore rispetto a quella che ha modificato per sempre la storia e il paesaggio pompeiano. Alcuni livelli vulcanici si vedono nelle successioni di scavo. Quelli più chiari, di colore grigiastro, sono delle eruzioni sempre del Vesuvio avvenute durante il periodo protostorico, altre durante il periodo preistorico, e sono stati di aiuto anche nell’inquadrare cronologicamente alcuni livelli archeologici presenti all’interno dei suoli. Per esempio alcune unità stratigrafiche, interpretate come paleo-suoli, hanno rivelato che questa era un’area boschiva, quindi un paesaggio completamente differente rispetto a quello urbano di Pompei. Le stesse stratigrafie hanno restituito anche materiali ceramici di età preistorica che ci fanno capire che nonostante l’area fosse fittamente boschiva era comunque frequentata da popolazioni preistoriche. Fino ad arrivare ad altre eruzioni che con il vulcanologo Sparice stiamo ancora cercando di determinare, che sono decisamente molto più antiche, quindi precedono di millenni la frequentazione preistorica di questo sito. Potrebbero anche venire da altri apparati vulcanici, come per esempio quello dei Campi Flegrei, o eruzioni di un Vesuvio primordiale che dobbiamo ancora riuscire bene a capire. Quindi la possibilità di accedere a queste informazioni stratigrafiche fino al sottosuolo profondo di Pompei ci fa capire che quest’area, nonostante gli eventi più significativi che hanno potuto determinare il cambiamento del paesaggio, è dovuta prevalentemente a eruzioni vulcaniche, che si susseguono nel corso dei secoli e dei millenni prima della fondazione di Pompei. Troviamo sempre gli stessi strati, cioè suoli ed eruzioni vulcaniche, il paesaggio muta di poco fino a quando si decide di costruire la città in questo punto. Infatti la parte alta delle stratigrafie che vediamo al di sotto della strada che doveva essere presente, mostra tutta una serie di tagli, buche, fosse, o la preparazione vera e propria del manto stradale. Quindi il cambiamento del paesaggio a partire dall’epoca storica viene determinato più dalle attività antropiche che si compiono nell’intera area di Pompei fino all’eruzione del 79 d.C. che determina la scomparsa e il cambiamento radicale di ogni forma del paesaggio”.

A partire dal giardino della Casa dell’Ancora e dalla Via dei Sepolcri viene, invece, il funzionario architetto Paolo Mighetto racconta il complesso lavoro multidisciplinare che sta alla base della gestione, conservazione e rinnovo del vasto patrimonio agronomico e paesaggistico del Parco Archeologico di Pompei.
Nella casa dell’Ancora c’è uno dei giardini di ultima generazione che si sta recuperando con la manutenzione. “Secondo me questo giardino illustra bene la multidisciplinarietà che sempre si è cercato di tenere nella gestione del verde di Pompei”, racconta Paolo Mighetto, “che è una gestione molto difficile. Pompei è un parco di quasi 100 ettari che spesso i turisti non colgono, perché conoscono i giardini delle domus che sono i più celebrati, ma il parco in realtà ha tutta una fascia extramoenia, quindi al di fuori delle mura, che comprende proprio delle aree estremamente interessanti anche aree agricole. Il giardino della domus dell’Ancora, nella Regio VI, nasce dal dato storico, archeologico e anche archeobotanico. Infatti anche la gestione del giardino, la messa a dimora di queste piante di edera e il trattamento delle piante nasce proprio da un’interpretazione delle pitture parietali, di come gli antichi potevano gestire questi giardini oltre che dai dati archeobotanici dei pollini. È un giardino concluso che impone anche svariati problemi di manutenzione. Ora stiamo proprio intervenendo anche sul tappeto erboso oltre che sulla potatura delle piante, sfruttando questo periodo di pandemia in cui il sito non è visitato dai turisti proprio per andare a fare degli interventi di rigenerazione del prato. Il grande discorso che stiamo portando avanti è anche sulla passeggiata fuori le mura. Negli anni ’80 già era stata fatta una grande bonifica in tutta l’area esterna di Pompei, quindi esterna al circolo delle mura per andare a eliminare tutte le infestanti, soprattutto la colonizzazione degli ailanti, questo albero infestante che distrugge il patrimonio. La città antica ha un’estensione di quasi 60 ettari. Ebbene tutto il parco archeologico di Pompei, un parco naturale, ha un’estensione di 100 ettari. Quindi l’area esterna alle mura con la passeggiata ha un’enorme estensione che costituisce una grande sfida per la manutenzione, per la gestione e anche una sfida per la progettualità della gestione del verde. Perché molte di queste aree, procedendo in questi anni anche i grandi cantieri di messa in sicurezza del sito, hanno avuto alcuni problemi di manutenzione legati anche al passaggio di mezzi di cantiere. Adesso è proprio il periodo in cui si stanno recuperando, perché diventerà una nuova area messa a disposizione dei visitatori e di un turismo che non solo ammirerà il sito archeologico, ma potrà godere anche di una visita naturalistica, di una visita paesaggistica straordinaria unica al mondo perché si collega con il territorio del parco del Vesuvio. Abbiamo avuto grossi problemi con gli alberi ad alto fusto soprattutto con i pini, perché sono colpiti da parassiti che ne determinano la rapida senescenza e quindi la necessità di abbattimento, e allora la sfida grande sarà quella di andare a ricostituire rapidamente questo patrimonio con un nuovo patrimonio arboreo. E quindi i programmi che si stanno portando avanti per l’imboschimento del parco archeologico prevedono anche la sostituzione di piante ormai morte ma che magari appartengono a specie non consone alla ricerca filologica che è stata fatta negli anni anche dal punto di vista botanico e archeobotanico, quindi non perfettamente coerenti con quello che il patrimonio della cosiddetta flora pompeiana. Perciò si sostituirà questo patrimonio perduto con nuovi alberi più coerenti con le scelte filologiche botaniche”.

E ancora una carrellata di immagini mette in evidenza alcune scene di paesaggio nella pittura pompeiana: a partire dalla Casa dei Ceii di recente restauro, con un confronto con le pitture della Casa del Menandro e dell’Efebo. Le scene di paesaggio nella pittura pompeiana, fra città e templi, campagne e boschi, grotte e marine, creano l’illusione che le dimensioni degli spazi siano diversi da quelli reali architettonici, come in una sorta di trompe-l’oeil, sviluppando l’idea di altre scenografie, non dissimili da quelle utilizzate nel teatro per la messa in scena di commedie o tragedie. Il paesaggio dipinto fa da sfondo alle rappresentazioni di figure mitiche o di attività umane che si muovono sulle pareti come in un’animazione teatrale. La prospettiva è ad imitazione del “reale”, così avviene ad esempio nel grande affresco che adorna il giardino della Casa dei Ceii, appena restaurato, dove troviamo una raffigurazione di sapore esotico molto apprezzata, con una scena di caccia condotta da animali selvatici disposti su più livelli, vista dall’alto in prospettiva, oggi diremmo “a volo di uccello”. Ai lati spaziano assolati paesaggi nilotici di origine alessandrina animati dagli scuri Pigmei, figurine esotiche e divertenti per i romani, considerati originari della parte più remota dell’Egitto, vicina all’Oceano, donde nasceva il Nilo.

Se ci spostiamo, rimanendo sullo stesso vicolo, nella prospiciente e lussuosa Casa del Menandro, anche il triclinio invernale è ravvivato al centro del pavimento con un raffinato emblema di paesaggio nilotico con gita di Pigmei, scena che poco dopo verrà addirittura replicata dallo stesso atelier nella Casa di Paquio Proculo. Graziosi paesaggi nilotici si ritrovano ancora nei quadretti che decorano i banchi del triclinio all’aperto della Casa dell’Efebo, con vivaci episodi ambientati nell’Egitto greco-romano.

Infine il Parco, per la giornata del Paesaggio, ripropone le immagini video del sito protostorico in località Longola di Poggiomarino, nell’alta valle del Sarno, a circa 10 chilometri a Est di Pompei. Il sito, di competenza del Parco Archeologico di Pompei, fa parte del Parco archeologico naturalistico di Longola, gestito dal Comune di Poggiomarino. Si trattava di un insediamento perifluviale in ambiente umido, frequentato dalla media Età del Bronzo fino al VI sec. a.C. L’elemento acquatico ha caratterizzato la vita del villaggio in tutte le sue fasi di vita e ha consentito anche la conservazione di numerosi materiali deperibili che costituiscono un eccezionale dossier archeologico e contribuiscono a fare di Poggiomarino un sito unico nel suo genere in Italia meridionale: esso colma un’importante lacuna sul popolamento della valle del Sarno, finora documentata soprattutto da contesti funerari, contribuendo in modo significativo alla ricostruzione delle dinamiche insediative nelle fasi che hanno preceduto la nascita di Pompei.
“All’interno del parco archeologico naturalistico di Longola”, spiega Antonino Russo, funzionario archeologo del parco archeologico di Pompei e responsabile del sito di Longola, “sono state ricostruite le capanne in maniera filologica e quanto più fedelmente possibile all’originale. All’interno delle capanne si svolgeva la vita dei gruppi familiari che abitavano il sito. La pianta delle capanne è di tipo rettangolare o absidata con una fila di pali centrale a sostenere il tetto a spiovente e pareti di rami intrecciati. All’interno delle capanne c’era generalmente un transetto che separava la zona abitativa da quella destinata a dispensa, quindi a contenere le derrate alimentari. Generalmente c’era poi un focolare dove venivano cotti i cibi. Il problema principale della vita degli abitanti di Longola, essendo un sito perifluviale, era l’acqua e comunque l’umidità per cui i piani delle capanne venivano continuamente bonificati con pietre pomici e rami intrecciati per alzare i piani e quindi tenersi all’asciutto dall’acqua. All’interno del villaggio queste capanne erano utilizzate sia ovviamente per uso abitativo ma anche per le varie attività di sussistenza che venivano svolte all’interno del villaggio, in particolar modo si lavorava il metallo, si lavorava l’osso, si lavorava il corno, le ambre. C’era chiaramente l’attività della lavorazione del legno, della produzione di ornamenti. Quindi la vita che si svolgeva all’interno delle capanne riguardava un po’ tutti gli aspetti della vita quotidiana degli abitanti del sito di Longola”.
Pompei. Si restaura la Schola Armaturarum a più di cinque anni dal crollo che costò il posto al ministro Bondi. Dalle macerie della Domus dei Gladiatori al Grande Progetto Pompei

6 novembre 2010: a Pompei è crollata la Domus dei Gladiatori, dove si allenavano gli atleti nell’antica Pompei
“Gravissimo danno al patrimonio artistico italiano: a Pompei è crollata l’intera Domus dei Gladiatori, così chiamata perché al suo interno gli atleti si allenavano e nella quale deponevano le armi all’interno di alcuni incassi ricavati nei muri”. Iniziava così l’articolo del Corriere della Sera on line del 6 novembre 2010, annunciando il crollo della Schola Armaturarum che sarebbe costato il posto al ministro per i Beni culturali dell’epoca, Sandro Bondi (si dimise nel marzo dell’anno successivo). “Secondo quanto si apprende dalla soprintendenza – continua-, vi erano anche dipinti nella parte sottostante il perimetro della sala. L’edificio, che si apre su via dell’Abbondanza, la strada principale della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. C., era visitabile solamente dall’esterno ed era protetto da un alto cancello in legno. Il crollo, secondo primi accertamenti, è avvenuto intorno alle ore 6 ed è stato notato dai custodi appena arrivati al lavoro verso le ore 7.30. L’area è stata transennata e non è possibile accedere. È stato predisposto un percorso alternativo per i turisti”. E poi il primo commento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: “Quello che è accaduto a Pompei dobbiamo, tutti, sentirlo come una vergogna per l’Italia. E chi ha da dare delle spiegazioni non si sottragga al dovere di darle al più presto e senza ipocrisie”. La risposta del ministero fu immediata per voce di Roberto Cecchi, segretario generale del Mibac: “Questo ennesimo caso di dissesto ripropone il tema della tutela del patrimonio culturale e quindi della necessità di disporre di risorse adeguate e di provvedere a quella manutenzione ordinaria che non facciamo più da almeno mezzo secolo. La cura di un patrimonio delle dimensioni di quello di Pompei e di quello nazionale non lo si può affidare ad interventi episodici ed eclatanti. La soluzione è la cura quotidiana, come si è iniziato a fare per l’area archeologica centrale di Roma e per la stessa Pompei”. E il ministro Bondi: “Quanto è accaduto ripropone la necessità di disporre di risorse adeguate per provvedere a quella manutenzione ordinaria che è necessaria per la tutela e la conservazione dell’immenso patrimonio storico artistico di cui disponiamo. Il crollo ha interessato le murature verticali Schola Armaturarum che erano state ricostruite negli anni Cinquanta, mentre parrebbe essersi conservata la parte più bassa, la parte cioè che ospita le decorazioni affrescate, che quindi si ritiene che potrebbero essere recuperate. Allo luce dei primi accertamenti, il dissesto che ha provocato il crollo parrebbe imputabile ad uno smottamento del terrapieno che si trova a ridosso della costruzione per effetto delle abbondanti piogge di questi giorni e del restauro in cemento armato compiuto in passato”.
Sono passati più di cinque anni da quel tragico crollo che portò il sito di Pompei all’attenzione del mondo. E dall’antica città romana, distrutta nel 79 d.C. da un’eruzione del Vesuvio, arrivano finalmente buone notizie: avviati gli interventi di recupero della Schola Armaturarum, posta su via dell’Abbondanza, all’angolo con il vicolo di Ifigenia (Regio III, Insula 3, Civico 6). Dopo il dissequestro dell’edificio nello scorso mese di dicembre, ricorda la soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, sono iniziati i lavori di recupero di quello che un tempo fu luogo di riunione di una associazione militare. Gli interventi attuali consistono nella realizzazione di coperture a protezione delle pareti affrescate originali, ovvero di quelle porzioni di mura che già miracolosamente si salvarono al bombardamento del 1943 e a cui negli anni ’50 seguì il restauro delle parti crollate e il rimpiazzo in cemento armato del soffitto. Gli interventi di copertura sono propedeutici agli interventi di messa in sicurezza dell’edificio, in attesa di valutare la possibilità di ricostruire in futuro le parti crollate, già non più originali a seguito del bombardamento e ridar così forma e volume idealmente all’edificio. Termine dei lavori febbraio 2016. Quindi in un secondo momento si valuterà se ed eventualmente come ricostruire la “Schola”.

Il governo Berlusconi avviò un progetto straordinario di messa in sicurezza e di manutenzione degli scavi sfociato nel Grande progetto Pompei
Dopo il crollo del novembre 2010, il governo Berlusconi, attraverso i ministri prima Galan, subentrato a Bondi, e poi Fitto, avviò su sollecitazione del commissario europeo Johannes Hahn un progetto straordinario di messa in sicurezza e di manutenzione degli scavi, perfezionato dal governo Monti (ministri Barce e Ornaghi). L’area venne intanto sottoposta a sequestro dalla procura di Torre Annunziata. Il Grande progetto Pompei da 105 milioni di euro fu inviato all’Ue a dicembre 2011 e approvato a febbraio 2012, i primi bandi pubblicati ad aprile. Ma per lunghi mesi la Schola è rimasta così, recintata e inaccessibile, coperta da teli bianchi a ricordare a visitatori e istituzioni che Pompei resta un luogo fragile, dove non bisogna mai smettere di vigilare e intervenire. “Il dissequestro della Schola armaturarum avvenuto nel corso dell’anno appena conclusosi (2015, ndr) e, finalmente, l’inizio dei lavori di copertura delle pareti affrescate originali, ovvero di quelle porzioni di mura che già miracolosamente si salvarono al bombardamento del 1943 cui seguì il restauro delle parti crollate e il rimpiazzo in cemento armato del soffitto”, sottolinea il soprintendente Massimo Osanna, “si colloca in un momento “storico” che non può che risultare simbolico. I lavori partiti due settimane fa sono anch’essi espressione di quella rinascita generale del sito che, finalmente, viene percepita dal pubblico e dalla stampa, ma che soprattutto coincide con attività concrete, quelle dei cantieri del Grande progetto e di interventi a lungo attesi, come questo della Schola. L’obbiettivo finale al quale stiamo lavorando è, al momento, quello di proteggere le strutture dell’edificio per poi pensare alla migliore soluzione di restauro dello stesso, che soprattutto consenta al pubblico di continuare a godere tangibilmente di un altro pezzo della storia di questa città antica”.
La struttura di copertura temporanea consisterà in tre ali larghe di circa tre metri, che seguono e inglobano il perimetro dell’edificio storico, con appoggi disposti all’interno dello stesso e lungo il perimetro esterno. Il perimetro della struttura sarà schermato da un sistema di teli microforati di pvc, stampati con testi e immagini sull’intervento in corso così da permettere una buona visibilità interna, una certa schermatura dall’irraggiamento solare diretto e una buona comunicazione per la fruizione e valorizzazione turistica. Previsto anche il diserbo di tutta l’area della Schola, la risagomatura del terreno dell’ambiente a nord dell’ambiente principale e la formazione di una trincea drenante retrostante alla parete ovest. Una volta montata, le murature affrescate saranno liberate dai teloni plastici che le hanno protette per questi cinque anni, e potranno entrare in campo i restauratori, per operare al coperto e senza che pioggia o sole interferiscano con le operazioni. Gli interventi in programma per un valore complessivo di circa 80mila euro sono stati coordinati dal responsabile unico del procedimento Cesira d’Innocenzo, dal direttore archeologo dei lavori Paolo Mighetto e dal direttore operativo archeologo Mario Grimaldi, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Mariano Nuzzo e per il rilievo laser scanner dall’architetto Raffaele Martinelli. “Abbiamo immaginato una struttura reversibile”, spiega l’architetto Paolo Mighetto, del gruppo di progettazione della segreteria tecnica della soprintendenza Pompei, “semplicemente appoggiata sul manufatto antico. Dopo il restauro conservativo delle pareti ovest, nord ed est della Schola, sulla base dei risultati scientifici che avremo acquisito si potrà procedere alla sistemazione definitiva dell’edificio”.
 “Ben…Essere Persone Cultura Sostenibilità e Territorio… Il parco archeologico di Pompei e la sua gente” è il titolo della tavola rotonda che mette al centro il benessere della persona, promossa dalla Cooperativa Il Tulipano, che si occupa di percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone con autismo e/o disabilità cognitiva, e dal liceo Pascal di Pompei col patrocinio del Festival dello Sviluppo sostenibile. Appuntamento all’auditorium di Pompei scavi martedì 21 maggio 2024 dalle 10.30 alle 14.30, con ingresso da piazza Esedra. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria a
“Ben…Essere Persone Cultura Sostenibilità e Territorio… Il parco archeologico di Pompei e la sua gente” è il titolo della tavola rotonda che mette al centro il benessere della persona, promossa dalla Cooperativa Il Tulipano, che si occupa di percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone con autismo e/o disabilità cognitiva, e dal liceo Pascal di Pompei col patrocinio del Festival dello Sviluppo sostenibile. Appuntamento all’auditorium di Pompei scavi martedì 21 maggio 2024 dalle 10.30 alle 14.30, con ingresso da piazza Esedra. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria a 




















Commenti recenti